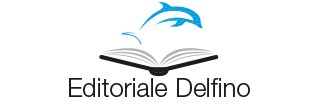Il recente decreto attuativo per accedere ai vantaggi della Transizione 5.0 ha riportato alla ribalta un aspetto che molti sottovalutavano: la necessità di misurare i nostri processi. Il concetto di misura mi riporta alla memoria vecchi studi di metrologia ed, in particolare, la definizione che ci insegnava Lord Kelvin asserendo che «se scienza significa misurare, senza la metrologia non ci può essere scienza.». In poche parole, misurare significa conoscere. Dal punto di vista scientifico la misura è un’indagine sul mondo fisico per ottenere informazioni quantitative e si caratterizza attraverso un modello, un metodo, una unità ed un campione di riferimento.
Sperimentalmente ogni rilevazione deve essere riproducibile, ripetibile e rispettare la proprietà di riferibilità, ovvero potere essere rapportata con valori noti ed appropriati. Dopo essere state acquisite, queste informazioni devono essere comunicate per cui è necessario rispettare l’intersoggettività degli interlocutori che devono comprendere il messaggio veicolato. Noi però viviamo in una società dell’informazione dove tutto viene monitorato e quantificato. I dati e le informazioni ottenute dalla loro elaborazione si comprano, si vendono e diventano la base per le decisioni strategiche.
A tal proposito, John Hauser e Gerald Katz in una loro pubblicazione (Metrics: You are what you measure!), sostenevano che «Ogni misurazione, che sia utilizzata esplicitamente per influenzare un comportamento, per valutare strategie future o, semplicemente, per fare il punto, influenzerà azioni e decisioni.» Questa affermazione dovrebbe aprire gli occhi e lanciare un allarme su come si scelgono e, soprattutto, misurano gli obiettivi. I cosiddetti KPI sono spesso considerati “solo” strumenti di pura “osservazione” ma, in realtà, hanno la capacità di influenzare le decisioni. A dimostrazione di ciò prendiamo come esempio una azienda che ha un prodotto di punta e tende massimizzarne l’espansione. Focalizzarsi su un singolo prodotto porterà a creare degli indicatori che trascureranno altri aspetti non meno importanti.
Proviamo ad immaginare quindi uno scenario con una azienda che ha scelto un gruppo indicatori a, b e c, e di non considerare importanti x, y e z. I responsabili delle singole funzioni saranno portati a prestare molta più attenzione ai primi e meno ai secondi. La concentrazione sui risultati determinerà, dopo un tempo più o meno breve, riconoscimenti o avanzamenti di carriera per coloro che hanno ottenuto buoni risultati in a, b e c. Forti delle promozioni ottenute, i responsabili saranno portati a spronare i propri dipendenti in modo da migliorare ancora le prestazioni sugli indicatori osservati e così via. L’azienda tende così, gradualmente, a diventare ciò che essa stessa misura! Secondo questa teoria è facilmente deducibile che gli indicatori prenderanno il controllo dell’azienda.
La conclusione di Hauser e Katz porta a dire che quando la massimizzazione di a, b e c porta a un incremento dei profitti di lungo periodo, gli indicatori si dicono efficaci; se, al contrario, ciò non avviene il loro effetto si dice non efficace o negativo. Molto semplicemente si può vedere una certa convergenza tra il significato della misura scientifica di Lord Kelvin e gli indicatori di prestazione di Hauser e Katz: entrambi si riferiscono alla necessità di trovare un comune linguaggio di comunicazione. All’interno delle aziende, usare lo stesso “idioma” dovrebbe aiutare gli stakeholder a focalizzarsi sull’obiettivo e, parallelamente, non trascurare il contorno che può apportare correzioni di rotta. In conclusione l’insegnamento di Metrics! è chiaro: misura gli obiettivi principali ma controlla e non perdere di vista gli obiettivi secondari perché, se cambia il contesto, potrebbero rivelarsi un strategico fattore critico di successo.